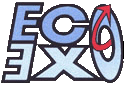Pietro A. Zveteremich
Gli eredi di Bobok
Quest'assenza di sentimentalismo, della quale parla Norman Mailer, si ritrova nei nuovi russi, in primo luogo Erofeev e Limonov a onta della grande differenza tra i due. Quanto Erofeev è furente e proiettato al di fuori, Limonov è introiettato e mite e buono. La bontà e l'amore rifuggono dal sentimentalismo e, affinché siano cose vere, oggi devono essere espressi, come fanno i nostri due, come fanno gli americani e altri, come fanno i giovani d'oggi in genere e in tutto il mondo, con un vocabolario immediato e violento, quello cioé che non passa attraverso le mediazioni create dalla società per una meno sgradevole convivenza: le mediazioni della cultura, dell'educazione, del buon gusto. Ma in ciò i russi in genere e in particolare Erofeev e Limonov, che ci interessano per questo discorso, sono differenti da Burroughs e da Bukowski, che in loro c’è molto amore: amore per la vita, per qualcuno, per le cose, perfino per se stessi. Burroughs odia anche i paesaggi. A lui manca lo slancio d'amore verso la vita e tutte le sue manifestazioni, quello che in russo è detto zizneradostnost', ossia l'erotismo nella sua accezione più lata e vera, che Erofeev e Limonov hanno in grande copia ed esprimono anche nelle situazioni più tragiche, più abbrutenti, più nefande. L'anima? Si può anche chiamare così. Quella dell'erotismo panteistico di Tolstoj quella suppliziata e anelante di Dostoevskij, quella stregonesca di Gogol'... fino al nostro secolo: quella drammatica di Blok, maligna di Sologub, panteistica ancora di Pasternak e di Platonov in due così diverse incarnazioni poetiche. Tralasciamo altri riferimenti.
Tornando ai nostri: Erofeev gronda come sangue dolore amore per la sua Russia (« Oh, infami! Hanno ridotto la mia terra nel peggiore inferno di merda e obbligano a nascondere davanti alla gente le lacrime e a esibire il riso! ...Oh, infime canaglie! Non hanno lasciato nient'altro che 'dolore' e 'paura' e, dopo di questo, il riso da loro è cosa pubblica e la lacrima è posta sotto divieto!... » 54) e precipita in un abisso infernale dove, vulnerato dalla sua stessa anima e dall'alcool, nell'oscurità, sotto le mura del Cremlino, che « scintilla in tutta la sua magnificenza », viene gettato nel nulla; eppure il suo golgota è un gran carnevale: un recupero di vita e di realtà dove la sua anima trionfa e si espande al creato. Limonov, nel suo abisso di Brooklin, è un angelo caduto, ma rimane anche nell'abiezione un angelo. La sua vicenda nel testo è vissuta (non raccontata da fuori come fa Bukowski) ed egli, in fin dei conti, soffre partecipando, ovvero ama il mondo se pur esso lo ferisce, lo umilia, lo respinge; di più, si diverte nella vita e alla vita, è in presa diretta con essa.
Per esempio: «Nella musica ovattata, sorseggiando da un enorme boccale la mia vodka, per contrasto andavo ricordando i miei amici della settimana, i barboni del ponte di Brooklin e ridevo. Eccola, puttana, la civiltà, e come non aver paura che un giorno gigantesche ondate, sollevandosi dagli antri di Brooklin e del basso East-Side arriveranno tanto in alto da coprire, per il c....!, le piccole isolette su cui si svolge il `Banchetto in tempo di peste`(*); si riversano le note d'una musica viscerale, baluginano quasi nudi i culi dei gay e va la mia Elena facile per tutti. E, con il c....!, nessun'America provinciale, quella delle casette a un piano solo, salverà nessuno; tutto sarà come vorrà New York: la mia grande e fiammeggiante città... » (55).
Se in tutta l'opera di Eduard Limonov, che presenta anche varie raccolte poetiche, il protagonista immutabile è l'autore, e la sua è sempre la « confessione d'un figlio del secolo », Erofeev è uscito dall'« io lirico » di Mosca-Petuski, o meglio l'ha sfaccettato e impegnato nell'esercizio critico di fronte a Rozanov e nella tragedia corale della Notte di S. Valpurga. Come si sa, Vasilij Rozanov è uno dei più sottili e contraddittori scrittori russi a cavallo dei due secoli, appassionato esegeta di Dostoevskij, di cui rivisse e tentò d'estendere la problematica; indagatore dei rapporti tra religione e sesso, tra misticismo ed erotismo panico. Una figura del genere non poteva non interessare Erofeev, il quale ne è stato mosso per un conte philosophique. La scoperta di Rozanov lo distoglie dal suicidio, assolvendo una funzione liberatoria e di riconquista della vita.
La notte di S. Valpurga è presentata dall'autore come: « il primo tentativo drammatico... una tragedia in cinque atti, che deve costituire la seconda parte del trittico « Drei Nachte ». La prima, notte, La notte di Ivan Kupala (o più semplicemente I dissidenti) è fatta per ora soltanto per un quarto e promette di essere la più allegra e la più funesta per tutti i suoi personaggi. Anch'essa è una tragedia e anch'essa in cinque atti. La terza: La vigilia di Natale ho intenzione di finirla per l'inizio di quest'inverno... Erste Nacht in un centro d'accettazione di bottiglie vuote; Zweite Nacht nel 31° reparto d'una clinica psichiatrica; Dritte Nacht in una chiesa ortodossa... E il tempo: sera - notte - alba » (56). Erofeev è germanista: usa volentieri il tedesco e per la sua tragedia prescrive un accompagnamento di musiche di Mahler e di Bruckner, non casuali per il loro misticismo, pessimismo e titanismo.
I titoli stessi delle tragedie previste per il trittico sono allusivi: così La notte di Ivan Kupala è la notte di S. Giovanni, nella paganità slava sacra ai riti orgiastici del solstizio d'estate; la notte di S. Valpurga è per tradizione germanica quella del sabba, del raduno orgiastico di streghe, demoni e spiriti. E tali, infatti, non possono non essere i personaggi, ricoverati ìn un manicomio e dunque « assatanati ». Ma chi sono? Innanzi tutto Gurevic, l'ultimo ricoverato, il quale, per vendicarsi delle sevizie subite da parte del sadico sanitario Mordovorot, trama per far saltare in aria il manicomio. Il piano fallisce, perché nella notte i pazienti si abbandonano a un'epica orgia alcoolica. Essa si conclude tragicamente con la morte di tutti: l'alcool rubato da Gurevic è metilico e li avvelena. Come il treno di Mosca-Petuski era un microcosmo della società sovietica, così lo è il manicomio di questa tragedia. Non può mancare il dissidente, che è qui il difensore del popolo Alecha; ma lo stesso Gurevic, il quale naturalmente è di cervello fine e tutt'altro che pazzo, è un anomalo, un diverso: è un ebreo. Tale è nella mentalità popolare nella società sovietica, come già in quella zarista, l'ebreo che anche la Cvetaeva in una sua poesia giovanile (57) aveva sotto questa luce ravvisato. Tutto nella tragedia è allegorico: il titolo, il luogo dell'azione, il tempo, l'ebreo Gurevic con un ruolo centrale, il caporeparto che imperversa con i suoi torrenziali commenti in linguaggio sovietico stereotipato di popolano saputo, il Dissidente, il sognatore Sereza Klejnmichel', che direi di stampo platonoviano, fino al contrammiraglio Michalyc « agente della CIA ».
Secondo i critici P. Vajl' e A. Genis « La notte di S. Valpurga, come le altre cose di Erofeev, è pervasa dal pathos della ricerca di Dio. Erofeev opera sempre con la poetica dei testi del Nuovo Testamento, utilizza abbondantemente il simbolismo cristiano. I suoi libri sono variazioni contemporanee dei misteri religiosi. L'autore in esse associa le verità rivelate a personaggi sacrilegamente degradati. Il turpiloquio, l'alcool, la follia non impediscono ai suoi personaggi di parlare sempre di Dio. Si può immaginare La notte di S. Valpurga come una modificazione contemporanea dell'Apocalisse. E, sebbene una simile lettura della pièce non ne escluda altre, essa a noi sembra la più fertile » (58).
Come ipotesi di lavoro, tale lettura può essere in effetti utile e condurre a determinati risultati, ma più produttiva - e in fondo in contraddizione con essa - pare l'osservazione degli stessi critici, da me pienamente condivisa - che « le persone qui raccolte da Erofeev sono idee che rappresentano determinate tendenze, che realmente esistono fuori del manicomio »; e inoltre che « nelle loro parole si riflette un modello filosofico della patria depurato dai dettagli inutili » (59). Per tutti i suoi elementi la tragedia ha invero la sostanza di una menippea, come già Mosca-Petuski, e nell'ambito di essa, come in quel breve romanzo, si svolge un grandioso dibattito di idee. E' difficile che uno scrittore così « smaliziato, colto, padrone di tutti i ferri del mestiere » (60), come scrivevo già anni fa, non conosca la lezione di Bachtin sul pensiero polifonico dostoevskiano e sulla menippea, e non ne abbia tenuto conto. Tanto più che l'elemento dialogico, la combinazione di fantasia sfrenata e d'uno scopo filosofico-ideale, del momento mistico-religioso e del naturalismo sordido, precisamente secondo la ricetta bachtiniana, sono caratteristiche di tutta la sua opera. A escludere l'ipotesi che La notte di S. Valpurga possa essere definita entro i limiti d'una Apocalisse e non invece ritenuta piuttosto come una menippea sono appunto questi dati, e inoltre la considerazione che un'Apocalisse è un'opera chiusa mentre la menippea è sempre un'opera aperta. E gli stessi critici di cui sopra sottolineano nel medesimo loro scritto ma in contrasto con quanto da loro detto più sopra questo carattere della tragedia di Erofeev: « Qualsiasi deduzione dell'autore viene immediatamente da lui stesso sottoposta a un ripensamento ironico. Egli non mette in nessun posto un punto definitivo » (61).
Sì, anche in questa tragedia, come già nel romanzo, Erofeev è apocalittico, ma quest'elemento è sempre subordinato al grottesco e alla satira. Per esempio: « Se non esiste più Lisbona, i restanti continenti sprofonderanno da soli... A cominciare dall'Oriente asiatico. Questo deleterio e sinistro assembramento di impurità non ha il diritto di esistere! Eccovi un'iscrizione orientale su una pietra tombale, e pure dei tempi evangelici! 'Beniamino di tutti, era pieno di grazia. Non risparmiando alcuno, sterminò tutti senza pietà'. Ebbene, che cosa ordinate di fare con popoli siffatti? Non fare niente, ecco! Creperanno da se stessi. Di continuo da loro rimbombano esplosioni demografiche, foruncolosi, Hiroshima, napalm, Nagasaki, e in genere non c'è niente da pappare. S'estingueranno quietamente da soli a purificazione della terra e dei cieli! E a tutto il resto daranno i1 colpo dl grazia l'encefalite iaponica, la rissa delle dittature marxiste e la febbre di Manciuria! Si avvicinano le scadenze della Creazione! Beviamo, cari confratelli, per avvicinare queste scadenze »! Ancora: « E così io vi condurrò per il sentiero del tuono e del sogno! E la stella a sei punte di David sarà per voi guida e foriera di destino!... Dicono che la stella del suo dissoluto figliolo Salomone era già a cinque punte. Questo non ci confà, avendo Solomon Davidyc capi-ottocento di concubine e... - Teh, a qual punto ci si può sputtanare: una stella a cinque punte! - Evviva Eretz Israel fino all'Eufrate! - Perché restringere? Dal Nilo all'Eufrate »! Quanto alla Russia: « Oh, in principio, si capisce, la nazione russa si sentirà felice e trionfante... Ma poi... Infettati da tutti i malanni dei vinti, anch'essi si ammaleranno e nulla resterà del passato gigantismo, si dissiperanno come polvere sulla faccia della terra. 0 meglio, saranno trascinati dai monsoni provenienti da Giaffa, trascinati sempre più lontano dalla parte degli spazi senza vita.., sempre più lontano verso nord, dove le giornate sono ancor più nuvolose, ancor più corte, e dove, di conseguenza, morire è ancor più indolore e leggero. Francesco Petrarca. Ed ecco, mentre i russi volano nell'abisso che gli è predestinato, il popolo di Geova... » (62).
Continui sono i riferimenti all'attualità, un'altra caratteristica del genere nel quale l'opera va a collocarsi (il fanatismo arabo, il petrolio, Antonov e l'attentato di Piazza S. Pietro, i cosmonauti, ecc. ecc.) e continui sono i collegamenti non soltanto stilistici, bensì tematici con Mosca-Petuski. A conclusione, si può concordare con Vajl'-Genis dove scrivono: « Nel corso di due decenni Venedikt Erofeev accompagna la realtà sovietica in qualità di commentatore filosofico. Ma ciò non significa che egli la spieghi. No, ogni volta egli crea il proprio modello della Russia, in cui la realtà viene spinta all'assurdo, deformata in un panorama surrealistico difficilmente riconoscibile. E tuttavia il modello del mondo erofeeviano è talmente completo, talmente profondo, che' precisamente in base a esso noi possiamo giudicare dello stato in cui si trova l'anima russa. La letteratura che Erofeev scrive è epocale nel senso che essa non condensa i sintomi esteriori dei fenomeni, ma esclusivamente la loro essenza interiore, profonda. Né lui, né i suoi personaggi si preoccupano di minuzie. Li agitano soltanto le questioni estreme, fatali, cioè filosofiche. Quest'approccio alla creatività consente alle brevi opere di Erofeev di diventare enciclopedie del giorno d'oggi » (63).
Una vibrazione poetica e tragica permea tutta l'opera di Erofeev. In questo è ancora la sua grandezza: che su una gran carnevalata, peraltro in sé vitalissima e vivissima, con un fuoco d'artificio d'effetti comici, surreali, mostruosi, assurdi, e con la puntualità e ferocia dei suoi riferimenti satirici, con la sua carnosa e carnascialesca realtà quotidiana russa e sovietica, trasfigurata a maggiore resa nel fantastico e nel grottesco, egli costruisce un'opera d'eccezionale profondità e ricchezza di significati.
Egli è dunque l'erede principe di Bobok, una figura geniale della letteratura russa d'oggi, ma tra gli altri eredi, fra i quali, su un piano d'alto magistero letterario, spiccano il sapiente Aksenov, l'assurdo Maramzin, il metafisico Mamleev, lo sperimentatore Sokolov, l'analitico e sboccato voyeur Jur'enen, il facondo Aleskovskij, emerge, per quella « confessione senza ritegno » alla quale s'è già accennato, Eduard Limonov. Se Erofeev s'investe della totalità della tragedia collettiva della nazione, Limonov la esprime come un sintomo attraverso se stesso. Egli è lirico quanto Erofeev è corale. Ma del suo diritto ad avere un posto di rilievo nella letteratura russa più nuova sono testimonianza le parole più che aggiornate d'un Aksenov: « Limonov abbandona l'ingrato ambiente di Char'kov per esprimere se stesso in letteratura e raggiunge questo scopo non peggio degli altri e perfino meglio » (64).
(Estratto da “Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Messina 4 (1986)
(54) V.Erofeev, Moskva-Petuski, op. cit., p. 156; ed. it.: op. cit., p. 159.
(*) Chiara allusione al celebre poema di Puskin.
(55) E. Limonov, op. cit., pp. 259, 270, passim.
(56) V. EroFeev, Val'purgieva noc ili..., op. cit., p. 96.
(57) M. Cvetaeva, Poesie, Rizzoli, Milano, 1967, p. 41; 2a ed., Feltrinelli, 1979, p. 39.
(58) P. Vajl'-A. Genis, op. cit., pp. 139-140. 59 Ivi, p: 142.
(59) Ivi, p. 142.
(60) P. Zveteremich, op. cit., p. 49.
(61) P. Vajl'-A. Genis, op. cit., p. 139.
(62) V. Erofeev, op. cit., pp. 175-178, passim.
(63) P. Vajl'-A. Genis, op. cit., pp. 138-139.
(64) V, Aksenov, Beguscie vdol' volny, « Obozrenie », Paris, N° 21, 1986, 24.