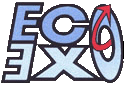Pietro A. Zveteremich
Gli eredi di Bobok
Anche G. Nivat si accosta a quest'interpretazione: « Tutte le parole d'ordine sono ingiuriate e profanate, e la liberazione alcolica riceve la propria corrispondenza stilistica attraverso le sconvenienze e il motteggio, attraverso la degradazione di tutta la cultura mondiale nel frasario e nel vomito d'un beone» (33). P. Vajl' e G. Genis, critici oggi noti, allora appena emigrati, si limitarono a riconoscere che « molto argento risuona sul cristallo della sua [di Erofeev] raffinata frase » (34), preferendo impostare la propria recensione sul motivo dell'alcolismo, che è quanto per prima cosa colpisce il lettore, giacché tutto il racconto ne è intessuto, anzi, di più, su di esso, si costruisce. « Mosca-Petuski - essi scrivevano - è la Confessione d'un figlio del secolo, è l' 'Eroe del nostro tempo', è il `Viaggio sentimentale'... Venicka [il protagonista] è venuto al mondo per lavarne gli occhi cisposi con la vodka. Per spiritualizzare un'esistenza senz'anima con un inventato mondo ebbro. Da tempo in Russia esiste un tale mondo. L'hanno creato la vodka e i libri. Talvolta un po' più di vodka, talvolta un po' più di libri. Ma la gente vive nell'inesistente nella stessa maniera normale in cui si vive in un alloggio in coabitazione... » (35).
Sembra a essi sfuggire l'essenziale e precisamente che qui ci troviamo bensì di fronte alla « confessione d'un figlio del secolo », ma che essa confessione non è quella d'un beone; che qui l'ubriachezza o, più, l'ossessione alcolica, è un procedimento del tutto consapevole, e - come già scrisse G. Mal'cev - « non un procedimento semplicemente formale, bensì la via del rifiuto, della fuga, della protesta e perfino della critica (è interessante la parodia della rivoluzione bolscevica data in questa chiave » (36). Altri critici hanno messo in rilievo quest'elemento determinante dell'opera. Nella sua recensione dell'edizione italiana non a caso V. Strada commentava: « Il sogno di Erofeev, che balena in impercettibili strappi della sua maschera ghignante è semplicemente quello di essere un uomo: nell'impossibilità di esserlo è l'aspetto terribile di questo documento » (37). W. Kasack: « Das ganze Buch ist eine sprachliche, in eine Eisenbahnfahrt gekleidete Gestaltung des urrussischen Lasters der Trinkerei. In den Worten eines Ich-Erzahlers nimmt der Leser an der sich steigernden Alkoholisierung teil. Die Berichte uber die sowjetische Realitat erhalten durch den sichmenhrenden Promillegehalt eine teils groteske, teils mildernde Verfremdung. Die Komik der Situation wird von Tragik aufgefangen » (38). Nella mia nota sull'edizione italiana io non volli neanche accennare al motivo dell'ebbrezza e dell'alcolismo, tanto è ovvio nel libro e tale da poter indurre a un'interpretazione deviante, ma in altra sede così ne parlavo: « Per la prima volta l'alcolismo, che pur appare in molte opere contemporanee e in modo anche marcato, qui, pur proiettato in una dimensione esasperata, è visto in tutta la sua ampiezza e profondità, nelle sue stratificazioni e varianti, nonché nelle sue tecniche... al punto di caricarsi d'una funzione poetica centrale. Ma, ben lontano dalla puntigliosa denuncia sociale, daMa se, come abbiamo visto, questa prima opera di Erofeev: Mosca-Petuski, da lui scritta nel '69, aveva avuto, specie da parte della critica russa, così tardivo e incerto riconoscimento, ecco che cosa scrivono del tutto di recente gli stessi P. Vajl'-A. Genis: «Ogni opera di Erofeev fa un bilancio di ciò che di fondamentale accade in Russia. Ogni suo libro è un importantissimo avvenimento. In base ai suoi libri si possono contare le tappe dell'evoluzione del pensiero russo » (40).
Che queste parole siano apparse su « Grani », con « .Novyj Zurnal » una delle due più togate riviste letterarie all'estero, è una vera consacrazione di Erofeev. Sono occorsi più di sedici anni dalla sua comparsa nel samizdat e tredici dalla prima edizione. Ma ora, dopo la pubblicazione del racconto-saggio Glazami ékcentrika (Con gli occhi d'un eccentrico) (41) e della tragedia Val'purgieva noc' ili « Sagi Komandora » (La notte di S. Valpurga ovvero « I passi del Kommandeur ») (42), anche alla critica egli s'è imposto con la statura che già avrebbe dovuto essergli riconosciuta per l'opera d'esordio. Oggi, sempre Vajl'-Genis scrivono: « Nella letteratura russa Erofeev svolge il ruolo d'una cometa. Vivendo in una specie di vuoto, egli ne fa apparizione di rado, ma fulgidamente. Essendo una persona non del tutto materiale, non è circondato da una biografia, ma da una leggenda. In compenso, sono ben materiali i suoi non frequenti libri, che egli fa giungere nella nostra cultura dalla sua enigmatica esistenza in un al di 1à » (43) . Ma ricordiamo che in un « al di là » vivono anche i personaggi di Bobok. Il loro è definitivo; quello d'Erofeev, speriamo, provvisorio.
Il fatto che non si sapesse - e non si sappia - nulla dell'identità e della vita di questo scrittore certamente è stato un motivo non accessorio della diffidenza così annosa verso di lui, ma probabilmente più l'ha suscitata, o comunque autorizzata, la novità stupefacente della sua opera e del suo linguaggio. Egli è stato il primo nella narrativa russa contemporanea a servirsi così ampiamente - e così produttivamente - del turpiloquio e della pornolalia. Con lui, con Juz Aleskovskij, con Niikolaj Bokov, con Viktor Erofeev (da non confondersi con il nostro), con Evgenij Popov, con Eduard Limonov, con Jur'enen, con Jurij Miloslavskij e altri questi elementi sono entrati nell'espressione letteraria insieme con la tematica del sesso. Da un lato ciò ha consentito un allaccio della letteratura con il folklore popolare e certe tendenze del '700; dall'altro lato ha costituito una liberazione, che la censura esterna e interna aveva sempre impedito (in questo limitando anche autori come Puskin, come Dostoevskij, per non citare i minori), e un'innovazione-arricchimento che la letteratura russa non aveva mai conosciuto.
Dai lettori del samizdat essa è stata assorbita in modo naturale, e si direbbe anche accolta con favore, considerando il grande successo e la diffusione clandestina di Erofeev e altri autori benché in Urss per queste letture si rischi la prigione. Al contrario, il fenomeno ha sconcertato e disorientato il mondo letterario dell'emigrazione (di quello sovietico non è possibile dir nulla, perché esso ufficialmente ignora questi scrittori e questi problemi). Così, a una « tavola rotonda » tenutasi nel 1980 a New York sul famoso almanacco « Metropol' » (44), un noto scrittore come Naum Korzavin affermava di rifiutare un tal genere di letteratura essendo egli « sostenitore del sistema classico di valori, della concezione classica dell'essenza e della destinazione dell'arte. E questa si riduce al fatto che l'arte non è semplicemente espressione di se stessi. Essa è anche Eucaristia » (45). Con ciò egli vuol intendere che l'arte deve perseguire nobili fini morali. Di vedute più larghe si dimostrava invece un pop, padre Smeman, il quale asseriva che: « L'unica cosa che in questi racconti si contrappone alla morte è il sesso » (46), rivelando chiare reminescenze di Bobok. Un altro pop, padre Fotiev, si spingeva a dare anche una giustificazione alla cosa, pur entro certi limiti: « ...Aleskovskij ha pronunciato qui un'allegra apologia del sesso in letteratura. Tema ricco, non c'è che dire. Specialmente dopo l'intollerabile, ipocrita `puritanesimo' della letteratura ufficiale, che potrebbe far invidia perfino alla regina Vittoria. Ma non è forse evidente che l'estremo opposto minaccia di distruzione la letteratura in quanto opera artistica? ... In Lolita di V. Nabokov singole pagine non sono per allieve d'istituto, ma il romanzo in sé è un tragico 'requiem del sesso', e non è questa cognizione, che in fondo alla coppa erotica vi sono sempre tristezza e dolore, ciò che salva il romanzo in quanto opera artistica? » (47). Ne consegue che il sesso in arte può presentarsi soltanto condannando se stesso o comunque come veicolo per dire altro, in ogni caso non può essere felice di sé. Grandi come Catullo, Boccaccio, l'Aretino, Rabelais dovrebbero esser tenuti fuori della letteratura. In Russia, infatti, non poterono manifestarsi autori del genere anche per il feroce controllo sempre esercitato dalla Chiesa ortodossa e dallo zarismo, mentre in basso, nel popolo, spumeggiava una irrefrenabile produzione in questo senso alla quale peraltro era preclusa la stampa. Il folklore ce l'ha in parte tramandata e ce ne ha dato testimonianza con opere raccolte dai massimi etnografi.
Il problema si riconduce a uno più vasto: quello del postulato, in Russia d'antica data (nel Medioevo di matrice religiosa; poi, politica e sociale; in Urss infine rigidamente monoideologico), secondo il quale l'arte esiste per qualcosa e non in sé, strumento e non fine, e che dunque possa-debba avere dei limiti che non sono semplicemente quelli a lei propri, intrinseci alla sua natura, bensì « altri », richiesti dalla società, gusto popolare o elitario che sia, quando non poi appunto ideologici. Il rimprovero ultimo, o meglio ricatto, che si fa a chi vuol superare tali condizionamenti, di cui in Occidente l'estetica ha da tempo sgomberato il campo, è d'aprire così la porta agli Erofeev e ai Limonov, visti come i continuatori sul terreno russo dei Céline, dei Miller, dei Burroughs.
Questo è un momento sul quale la critica non ha fatto sinora alcuna ricerca, ma c'è in ogni caso preliminarmente da asserire che la congiunzione della nuova prosa russa con la prosa americana è un dato di fatto, e che tuttavia essa non s'è operata prioritariamente sulla linea dell'aggiornamento della prima sulla seconda, dell'assimilazione dell'americana da parte della russa, bensì per ragioni intrinseche di quest'ultima, e dunque ragioni molto più profonde. E' la congiunzione, la convergenza di due itinerari completamente diversi che tuttavia, in ultima analisi, hanno avuto almeno un punto di partenza comune: lo spietato denudamento delle coscienze aperto in letteratura da Dostoevskij. La coltura delle spore dell'autocoscienza moderna da lui avviata secondo un pensiero artistico del tutto nuovo, passando attraverso il mondo della civiltà industriale, passando attraverso gli sconfinati spazi dell'America e della Russia - per rammentare anche solo due componenti determinanti, che sono comuni ai due paesi nonostante tutte le loro enormi differenze - ha in questi scrittori i suoi ultimi (e in ordine cronologico e in ordine ai risultati) adepti e ricercatori. Erofeev e Limonov, da questo punto di vista, sono, sul versante russo, i più geniali e fruttuosi. Il loro ritardo, come quello in genere dei russi, rispetto agli esiti della letteratura anglo-americana, è dovuto prevalentemente a cause esterne, quali condizionamenti di sviluppo, di tradizioni culturali, e molto di censura. In compenso, né in Miller, né in Kerouac, né in Burroughs, né tantomeno in Bukowski troveremo il diapason tragico, la sfida veramente all'ultimo sangue, il dissacramento crudele, l'incondizionato denudamento à la Bobok e la resa totale di se stessi che troviamo in Erofeev e in Limonov. Forse piuttosto In Céline e in Genét.lla triste descrittività della scuola naturalistica risalente ai Pisemskij e ai Resetnikov, Erofeev fa dell'alcolismo un qualcosa d'esplosivo e d'orgiastico, un elemento di vitalismo e di gioia di vivere, un veicolo di comunicazione universale » (39).
Ma se, come abbiamo visto, questa prima opera di Erofeev: Mosca-Petuski, da lui scritta nel '69, aveva avuto, specie da parte della critica russa, così tardivo e incerto riconoscimento, ecco che cosa scrivono del tutto di recente gli stessi P. Vajl'-A. Genis: «Ogni opera di Erofeev fa un bilancio di ciò che di fondamentale accade in Russia. Ogni suo libro è un importantissimo avvenimento. In base ai suoi libri si possono contare le tappe dell'evoluzione del pensiero russo » (40).
Che queste parole siano apparse su « Grani », con « .Novyj Zurnal » una delle due più togate riviste letterarie all'estero, è una vera consacrazione di Erofeev. Sono occorsi più di sedici anni dalla sua comparsa nel samizdat e tredici dalla prima edizione. Ma ora, dopo la pubblicazione del racconto-saggio Glazami ékcentrika (Con gli occhi d'un eccentrico) (41) e della tragedia Val'purgieva noc' ili « Sagi Komandora » (La notte di S. Valpurga ovvero « I passi del Kommandeur ») (42), anche alla critica egli s'è imposto con la statura che già avrebbe dovuto essergli riconosciuta per l'opera d'esordio. Oggi, sempre Vajl'-Genis scrivono: « Nella letteratura russa Erofeev svolge il ruolo d'una cometa. Vivendo in una specie di vuoto, egli ne fa apparizione di rado, ma fulgidamente. Essendo una persona non del tutto materiale, non è circondato da una biografia, ma da una leggenda. In compenso, sono ben materiali i suoi non frequenti libri, che egli fa giungere nella nostra cultura dalla sua enigmatica esistenza in un al di 1à » (43) . Ma ricordiamo che in un « al di là » vivono anche i personaggi di Bobok. Il loro è definitivo; quello d'Erofeev, speriamo, provvisorio.
Il fatto che non si sapesse - e non si sappia - nulla dell'identità e della vita di questo scrittore certamente è stato un motivo non accessorio della diffidenza così annosa verso di lui, ma probabilmente più l'ha suscitata, o comunque autorizzata, la novità stupefacente della sua opera e del suo linguaggio. Egli è stato il primo nella narrativa russa contemporanea a servirsi così ampiamente - e così produttivamente - del turpiloquio e della pornolalia. Con lui, con Juz Aleskovskij, con Niikolaj Bokov, con Viktor Erofeev (da non confondersi con il nostro), con Evgenij Popov, con Eduard Limonov, con Jur'enen, con Jurij Miloslavskij e altri questi elementi sono entrati nell'espressione letteraria insieme con la tematica del sesso. Da un lato ciò ha consentito un allaccio della letteratura con il folklore popolare e certe tendenze del '700; dall'altro lato ha costituito una liberazione, che la censura esterna e interna aveva sempre impedito (in questo limitando anche autori come Puskin, come Dostoevskij, per non citare i minori), e un'innovazione-arricchimento che la letteratura russa non aveva mai conosciuto.
Dai lettori del samizdat essa è stata assorbita in modo naturale, e si direbbe anche accolta con favore, considerando il grande successo e la diffusione clandestina di Erofeev e altri autori benché in Urss per queste letture si rischi la prigione. Al contrario, il fenomeno ha sconcertato e disorientato il mondo letterario dell'emigrazione (di quello sovietico non è possibile dir nulla, perché esso ufficialmente ignora questi scrittori e questi problemi). Così, a una « tavola rotonda » tenutasi nel 1980 a New York sul famoso almanacco « Metropol' » (44), un noto scrittore come Naum Korzavin affermava di rifiutare un tal genere di letteratura essendo egli « sostenitore del sistema classico di valori, della concezione classica dell'essenza e della destinazione dell'arte. E questa si riduce al fatto che l'arte non è semplicemente espressione di se stessi. Essa è anche Eucaristia » (45). Con ciò egli vuol intendere che l'arte deve perseguire nobili fini morali. Di vedute più larghe si dimostrava invece un pop, padre Smeman, il quale asseriva che: « L'unica cosa che in questi racconti si contrappone alla morte è il sesso » (46), rivelando chiare reminescenze di Bobok. Un altro pop, padre Fotiev, si spingeva a dare anche una giustificazione alla cosa, pur entro certi limiti: « ...Aleskovskij ha pronunciato qui un'allegra apologia del sesso in letteratura. Tema ricco, non c'è che dire. Specialmente dopo l'intollerabile, ipocrita `puritanesimo' della letteratura ufficiale, che potrebbe far invidia perfino alla regina Vittoria. Ma non è forse evidente che l'estremo opposto minaccia di distruzione la letteratura in quanto opera artistica? ... In Lolita di V. Nabokov singole pagine non sono per allieve d'istituto, ma il romanzo in sé è un tragico 'requiem del sesso', e non è questa cognizione, che in fondo alla coppa erotica vi sono sempre tristezza e dolore, ciò che salva il romanzo in quanto opera artistica? » (47). Ne consegue che il sesso in arte può presentarsi soltanto condannando se stesso o comunque come veicolo per dire altro, in ogni caso non può essere felice di sé. Grandi come Catullo, Boccaccio, l'Aretino, Rabelais dovrebbero esser tenuti fuori della letteratura. In Russia, infatti, non poterono manifestarsi autori del genere anche per il feroce controllo sempre esercitato dalla Chiesa ortodossa e dallo zarismo, mentre in basso, nel popolo, spumeggiava una irrefrenabile produzione in questo senso alla quale peraltro era preclusa la stampa. Il folklore ce l'ha in parte tramandata e ce ne ha dato testimonianza con opere raccolte dai massimi etnografi.
Il problema si riconduce a uno più vasto: quello del postulato, in Russia d'antica data (nel Medioevo di matrice religiosa; poi, politica e sociale; in Urss infine rigidamente monoideologico), secondo il quale l'arte esiste per qualcosa e non in sé, strumento e non fine, e che dunque possa-debba avere dei limiti che non sono semplicemente quelli a lei propri, intrinseci alla sua natura, bensì « altri », richiesti dalla società, gusto popolare o elitario che sia, quando non poi appunto ideologici. Il rimprovero ultimo, o meglio ricatto, che si fa a chi vuol superare tali condizionamenti, di cui in Occidente l'estetica ha da tempo sgomberato il campo, è d'aprire così la porta agli Erofeev e ai Limonov, visti come i continuatori sul terreno russo dei Céline, dei Miller, dei Burroughs.
Questo è un momento sul quale la critica non ha fatto sinora alcuna ricerca, ma c'è in ogni caso preliminarmente da asserire che la congiunzione della nuova prosa russa con la prosa americana è un dato di fatto, e che tuttavia essa non s'è operata prioritariamente sulla linea dell'aggiornamento della prima sulla seconda, dell'assimilazione dell'americana da parte della russa, bensì per ragioni intrinseche di quest'ultima, e dunque ragioni molto più profonde. E' la congiunzione, la convergenza di due itinerari completamente diversi che tuttavia, in ultima analisi, hanno avuto almeno un punto di partenza comune: lo spietato denudamento delle coscienze aperto in letteratura da Dostoevskij. La coltura delle spore dell'autocoscienza moderna da lui avviata secondo un pensiero artistico del tutto nuovo, passando attraverso il mondo della civiltà industriale, passando attraverso gli sconfinati spazi dell'America e della Russia - per rammentare anche solo due componenti determinanti, che sono comuni ai due paesi nonostante tutte le loro enormi differenze - ha in questi scrittori i suoi ultimi (e in ordine cronologico e in ordine ai risultati) adepti e ricercatori. Erofeev e Limonov, da questo punto di vista, sono, sul versante russo, i più geniali e fruttuosi. Il loro ritardo, come quello in genere dei russi, rispetto agli esiti della letteratura anglo-americana, è dovuto prevalentemente a cause esterne, quali condizionamenti di sviluppo, di tradizioni culturali, e molto di censura. In compenso, né in Miller, né in Kerouac, né in Burroughs, né tantomeno in Bukowski troveremo il diapason tragico, la sfida veramente all'ultimo sangue, il dissacramento crudele, l'incondizionato denudamento à la Bobok e la resa totale di se stessi che troviamo in Erofeev e in Limonov. Forse piuttosto In Céline e in Genét.
(Estratto da “Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Messina 4 (1986)
(33) G. Nivat, op. cit., p. 107.
(34) P. Vajl' - A. Genis, Strasti po Erofeevu, « Ècho », N. 4, 1978, p. 112. Anche in Sovremennaja russkaja proza, Hermitage, Ann Arbor, 1982.
(35) Ivi, pp. 109 e 114.
(36) J. Mal'cev, op. cit., p. 106.
(37) V. Strada, Viaggiando in un limbo grondante di vodka, « La Repubblica », 19. 8. 1977.
(38) W. Kasack, Die russische Literatur 1945-1982, Verlag O. Sagner, Munchen, 1983, p. 74. V. Erofeev non è tuttavia incluso nel suo pur ottimo "Lexikon der russischen Literatur ab 1917", pubblicato nel 1976 a Stoccarda.
(39) P. Zveteremich, Fantastico grottesco assurdo e satira nella narrativa russa d'oggi (1956-1980), Peloritana Editrice, Messina, 1980, p. 47. Si veda anche l'intero cap. "Il poema dell'emarginazione" (pp. 47-51).
(40) P. Vajl' - A. Genis, Soslagatel'noe naklonenie istorii, « Grani ». Frankfurt/M., N. 139, 1986, p. 138.
(41) V. Erofeev, Glazami èkcentrika, « Neue russische Literatur. Almanach », 1, 1978, Institut fur Slawistik, Salzburg; 2a ed.: Silver Age Publishing, New York, 1982, pp. 64.
(42) Cfr. n. 16.
(43) P. Vajl' - A. Genis, op. cit. p. 138.
(44) L'almanacco Metropol' uscì in unico esemplare a Mosca nel gennaio 1979 per iniziativa d'un gruppo di scrittori. Vietato in Urss, fu stampato negli Usa dalle edizioni russe Ardis. Un ampio ragguaglio è in: P. Zveteremich, La sfida di « Metropol' », « Nuova Rivista Europea », N. 14, 1979, pp. 17-50.
(45) Ob al'manache « Metropol' », « Grani », Frankfurt/M., N. 118, 1980, p. 137.
(46) Ivi, p. 151.
(47) Ivi, p. 155.
(Estratto da “Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Messina 4 (1986)